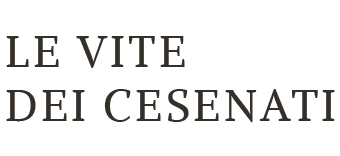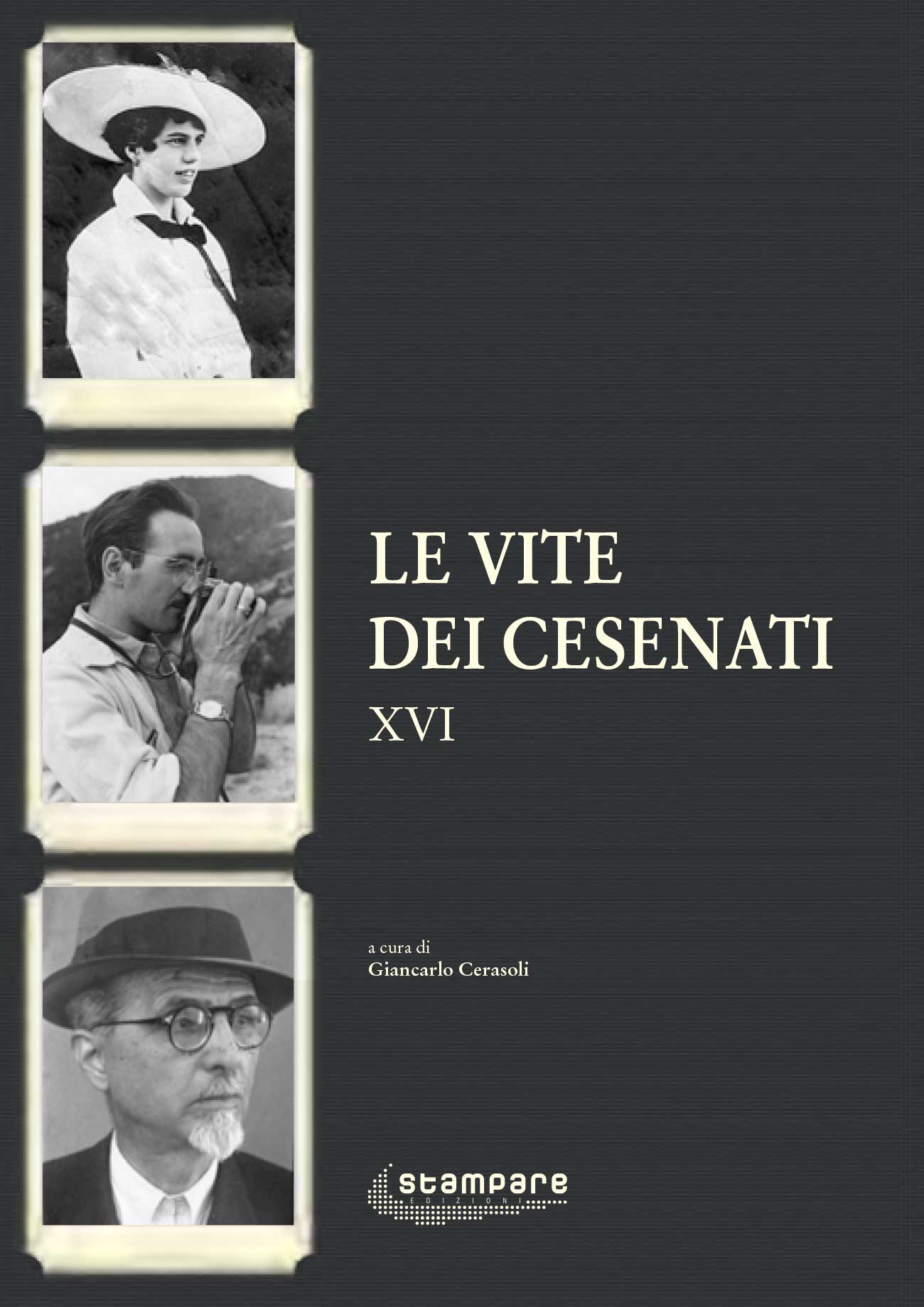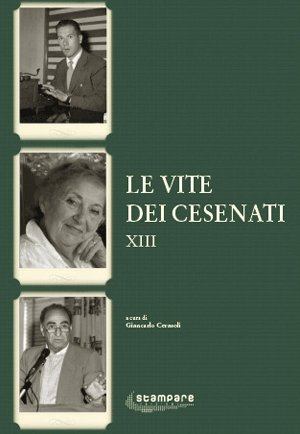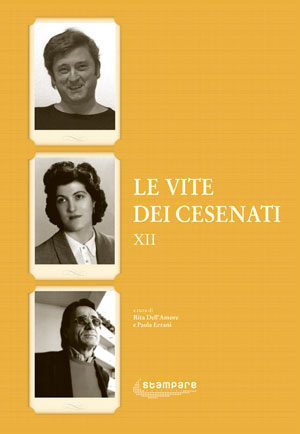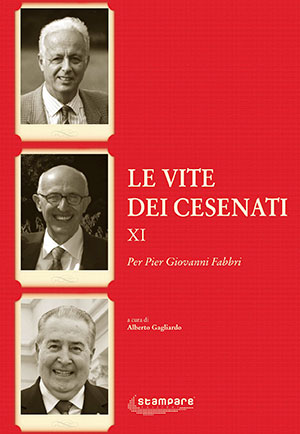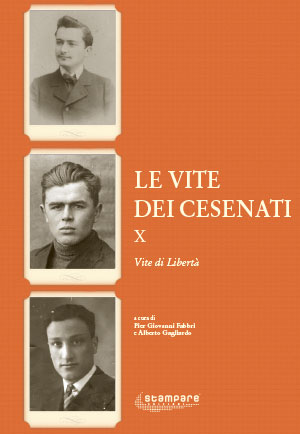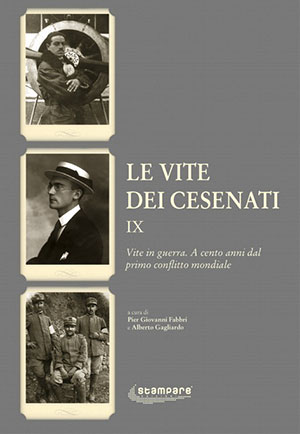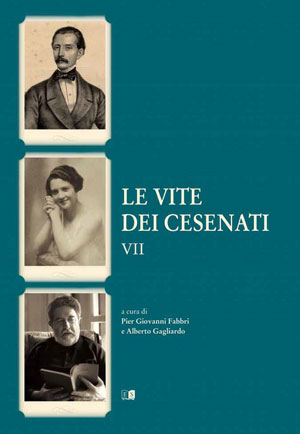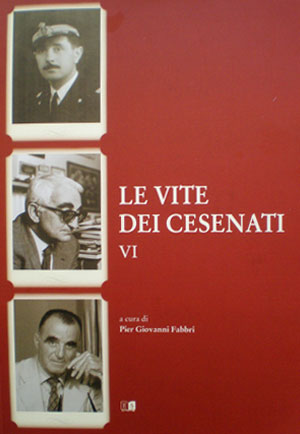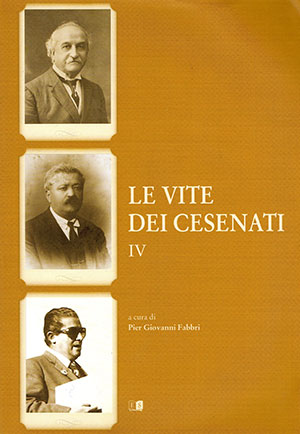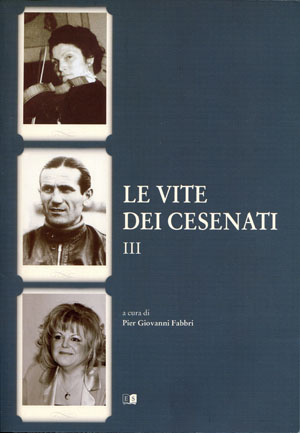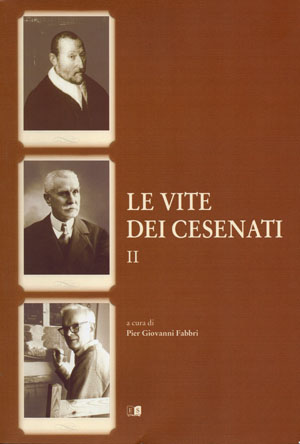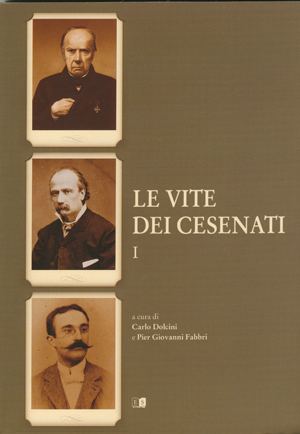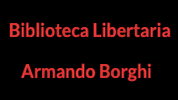Elenco foto:

Immagine2
Armando Golfarelli - Autodidatta pratica la pittura con fantasia ispirandosi soprattutto alla natura. <>.

Immagine3
Armando Golfarelli - «Sono marine splendide sotto la luce del tramonto o alquanto evanescenti sotto la luce del crepuscolo, o burrascose sotto un cielo sconvolto, ma cielo e mare, terra ed acqua, luce e penombra, vele e rematori e barche sono rappresentati con tanta armonia e con tanta naturalezza che il quadro, di solito piccolo, per mirabile suggestione come per incanto s’ingrandisce nella mente e acquista senza sforzo le proporzioni della realtà».

Immagine4
Armando Golfarelli - <>.

Immagine5
Armando Golfarelli - La figura, i greggi, le barche fuoriescono dallo sfondo e il fondale invade i soggetti nell’evanescenza.

Immagine6
Armando Golfarelli
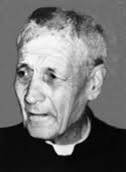
Immagine7
Don Carlo Baronio - 7 Il 25 luglio 1911 Carlo Baronio è ordinato sacerdote nella Basilica di Santa Maria del Monte. Nel 1919 si laurea alla facoltà di lettere dell’università di Roma con una tesi su Jacopo Mazzoni, difensore di Dante. Su consiglio del vescovo monsignor Giovanni Cazzani approfondisce gli studi di scienze sociali ottenendo nel 1923 il titolo di dottore presso l’Istituto Cattolico di scienze sociali di Bergamo.

Immagine8
Don Carlo Baronio - Don Carlo, fin dai primi anni di sacerdozio, volle vivere pienamente la sua appartenenza al Presbiterio diocesano, con riferimento cordiale e obbediente ai vescovi che si sono succeduti a monsignor Cazzani che lo aveva ordinato prete il 25 luglio 1911 nelle basilica di Santa Maria del Monte.

Immagine9
Don Carlo Baronio - E’ del settembre 1927 una sua commovente testimonianza: «Turbe di fanciullini si aggirano nelle nostre vie, si uniscono a stormi sopra un mucchio di ghiaia o attorno ad una fontana, e danno l’idea al passeggero che siano veramente i figli di nessuno».

Immagine10.2
Monumento a Don Baronio di Leonardo Lucchi

Immagine10
Don Carlo Baronio - I bambini di Don Baronio

Immagine11
Umberto Sama - Nel 1950 decise di fondare insieme a Pio Turroni e Pietro Gazzoni il «gruppo editore L’ Antistato».

Immagine12
Umberto Sama - Sempre negli anni cinquanta, assecondando la passione per i francobolli, fondò insieme ad altri amici il Circolo Filatelico di Cesena.

Immagine13
Silvia Belletti «Non illudetevi troppo, non sono un’eroina. Sono contenta di essere qui pur in mezzo a disastri e grattacapi. Ho lasciato una vita comoda che mi era diventata anche troppo facile, ma ho trovato un senso più profondo di esistere che è un po’ difficile da spiegare».

Immagine14
Oreste Vancini «La vita è un’affannosa corsa ad una meta che non si raggiunge mai e non è veramente vissuta se non quando è dedicata a un’idea». Il 25 giugno 1903 consegue la laurea in lettere discutendo la tesi dal titolo Un episodio della formazione dei grandi Stati d’Italia (1360 - 1377) con Giosuè Carducci.

Immagine15
Carlo Tedeschi e Giulia Vastano. Due medici attivi nel territorio cesenate tra il 1919 il 1927 Dopo aver concluso un brillante corso universitario, Giulia Vastano si laureò con il massimo dei voti il 10 luglio 1912, prima dottoressa in medicina uscita dall’Ateneo di Modena. Dall’ottobre 1919 il Tedeschi divenne chirurgo primario interino dell’Ospedale civile di Cesenatico ove, dal 4 novembre 1919 al 31 marzo 1921, effettuò 266 interventi chirurgici. (Il primo edificio a destra era l’ospedale di Cesenatico)

Immagine16
Carlo Tedeschi e Giulia Vastano - Dopo una serie di peregrinazioni in Italia, la famiglia si trasferì nuovamente, questa volta in Libia - allora colonia italiana - perché dal 7 ottobre 1927 Tedeschi divenne direttore e chirurgo dell'Ospedale coloniale di Derna (Libia). (Libia 1914, Foto LMP, BCM)

Immagine17
Antonio Manuzzi - Il nonno di AM era ortolano e diede inizio alla “Anonima Italiana Luigi Manuzzi e figli” con sede in Cesena. AM ne divenne amministratore delegato a 24 anni, nel 1926. In origine l’azienda si occupava di frutta e vino. Fu dalla sede, nei pressi della stazione ferroviaria, che iniziò un’attiva presenza nei mercati europei. Nel 1923 vennero spediti 187 vagoni ferroviari, nel 1933 i vagoni diventarono 1742 con prevalenza di pesche (43%). Negli anni ‘20 fu selezionata, dall’agricoltore Domenico Pieri, la “Bella di Cesena”. Al frutto il nome fu dato da AM e quella varietà fu diffusa in Europa soprattutto dalla sua azienda.

Immagine18
Antonio Manuzzi - Da un rapporto del consolato italiano in Svizzera: «Mi viene riferito che la direzione del PRI invierà in Svizzera nel prossimo marzo un certo Manuzzi Tonino di Cesena per eseguirvi un giro di propaganda e procedere alla riorganizzazione delle varie sezioni. Il Manuzzi giustificherebbe il suo viaggio con il commercio del vino al quale pare si dedichi. Pregasi disporre accertamenti al riguardo provvedendo a seconda delle risultanze a che sia rifiutato il passaporto al Manuzzi» . (Foto fondo Bruno Evangelisti)

Immagine19
Antonio Manuzzi - 1960. Congresso della consociazione cesenate del PRI.

Immagine20
Antonio Manuzzi - Il 13 ottobre 1956, a seguito della nomina a Sindaco di Cesena, fu sostituito in Consiglio Provinciale da Giovanni Gatti. Dal 9 settembre 1956 al 6 luglio 1968 fu sindaco di Cesena. AM è stato il sindaco della transizione fra due tipi di società. Da quella degli anni ‘50, di “pane, casa e lavoro”, della emigrazione in Europa fino a quella del boom economico degli anni ’60. (Foto fondo Bruno Evangelisti)

Immagine21
Antonio Manuzzi - 8 giugno 1983. Funerali di Antonio Manuzzi. I cittadini attendono l’uscita del feretro dalla camera ardente in comune. (Foto fondo Bruno Evangelisti)

Immagine22
Alieto Pieri - La sua produzione si può suddividere in cinque tipi: 1) manuali ed antologie scolastiche di latino e di greco; 2) saggistica filologica e traduzioni; 3) articoli di critica letteraria e teatrale; 4) opere di narrativa e di teatro; 5) altri scritti.

Immagine23
Alieto Pieri - Pieri insegnò al “Vincenzo Monti” dal 1962 al 1966; poi tornò in Toscana, a Prato e a Firenze, dove sarà insegnante e poi preside. Dal 1979 al 1985 fu direttore della Scuola Italiana di Atene e dal 1986 al 1993 diresse la Scuola Italiana di Parigi. Tornato in Italia fu ancora preside: ad Arezzo e a Firenze.

Immagine24
Alieto Pieri - Premio Firenze- Europa 2004. La ricerca di Pieri meritò il Premio di Filologia del Ministero dei Beni Culturali; ebbe recensioni specialistiche in cui si affermava che tra i molti titoli lucreziani comparsi negli ultimi cinquant’anni, in Italia e all’estero, quello di Pieri occuperà un luogo d’onore (V. D’Agostino).

Immagine25
Alieto Pieri - È una biografia in forma di romanzo, frutto di un’appassionata ricostruzione storica illuminata dall’amore per l’opera del poeta.

Immagine26
In vino sanitas: il vino nella medicina popolare romagnola

Immagine27
In vino sanitas: il vino nella medicina popolare romagnola - Le proprietà curative del vino derivano dalle caratteristiche dell’uva dalla quale è stato ricavato, dalla sua preparazione e conservazione e, nel caso fossero usate, dalle sostanze aggiunte ad esso per ottenere i cosiddetti vini medicinali. Nell’antichità sono state impiegate molte di queste bevande; dal vino cordiale a quello citonato, rosmarinato, granato, melico, scillino e tanti altri ancora.

Immagine28
In vino sanitas: il vino nella medicina popolare romagnola Al vino, oltre alla funzione nutrizionale, era attribuita un’importante valenza simbolica, al punto che uno dei vitigni più diffusi, il sangiovese, prendeva il nome dal «sangue di Giove». La gravida che desiderava avere un bambino con i capelli neri doveva bere, durante la gravidanza, vino nero e, viceversa, vino bianco se preferiva un bambino biondo.

Immagine29
In vino sanitas: il vino nella medicina popolare romagnola - De ven bon s t biré /e ‘ tu sangv t’arnuvaré [Se del vino buono berrai / il tuo sangue rinnoverai] Proprietà sia terapeutiche che magiche aveva il «vino della messa» il cui uso profano, condannato nei sinodi diocesani riminesi e faentini del Cinquecento, era richiesto per favorire la montata lattea della puerpera e per combattere la febbre. In vino sanitas: il vino nella medicina popolare romagnola

Immagine30.2
Carsteja de ven (Calendario degli Smembri 1853)

Immagine30
Funerale di un uomo morto per aver bevuto acqua (Calendario degli Smembri 1854)

Immagine31
Rino Albertarelli - Rino Albertarelli, «generosissimo narratore ed esemplare suscitatore di onirici incanti». «Ho cominciato a disegnare all’età di due anni. Mi piacevano i cavalli e ne disegnai alcuni sui margini di una filotea di mia madre. Più che cavalli, oggi, mi sembrano scarafaggi, ma con la testa, le zampe, gli zoccoli e l’occhio»

Immagine32
Rino Albertarelli - Il Mercante di Stampe scelse di dedicare una rassegna a Rino Albertarelli proprio come inventore del fumetto western italiano. Rino Albertarelli

Immagine33.2
Copertina de Il Cartoccino dei piccoli

Immagine33
Quarta di copertina di Grand Hotel

Immagine34.2
Rino Albertarelli

Immagine34
Rino Albertarelli

Immagine35
Rino Albertarelli - Quando si parla di fumetti italiani e degli egregi risultati ai quali essi giunsero negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, ma anche nel corso della stessa, si finisce inevitabilmente per citare il nome di Rino Albertarelli

Immagine36
Rino Albertarelli

Immagine37
Rino Albertarelli - Nel 1998, la Venticinquesima Mostra filatelica «Città di Cesena» , che si tenne al Carisport nei giorni 18 e19 aprile, ha omaggiato Rino Albertarelli con l’emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «ITALIA» e con l’annullo speciale, in data 18.4.1998, recante l’immagine di Toro Seduto e la dicitura «Omaggio a Rino Albertarelli. 7° premio Filatelia giovanile “M° Giunchi”»

Immagine38
Rino Albertarelli - Nel quinquennio tra il 1937 e il 1942, Rino Albertarelli venne completamente assorbito dai frenetici programmi editoriali dell’API (Anonima Periodici Italiani), il nome di allora della Divisione Periodici della Mondadori, collaborando praticamente a tutte le sue testate.

Immagine39
Recensione - Ma questo di Pedrelli non è solo un romanzo storico e non gli si renderebbe giustizia se non si dicesse che parte consistente della vicenda è occupata dalla storia d’amore tra la protagonista e il giovane partigiano Attilio, studente universitario di lettere.

Immagine40
Recensione - Tutto il discorso di Balzani è centrato sulla natura processuale del passaggio dei beni, con la loro storia materiale, alla immaterialità della realtà, cioè «delle reti di significato trapiantate nella memoria culturale». Questo passaggio può riguardare, quindi, il destino di una città o il successo di una élite; realtà che vanno quindi al di là dei beni che si intendono conservare o valorizzare.